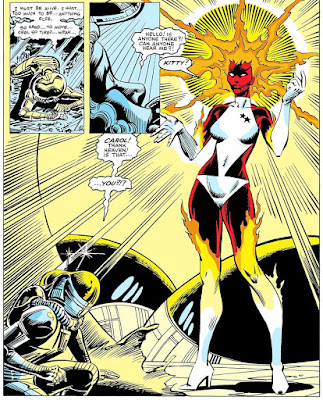“The End? L'inferno fuori”
dell'esordiente Daniele Misischia è un film italiano di genere. Ok.
Partiamo da questo dato scontato. E cioè che dopo un lungo silenzio,
qualcuno in terra italica torna a percorrere quei sentieri
dell'immaginario perturbante che nel nostro cinema è stato
consegnato alla storia da nomi del calibro di Dario Argento e Lucio
Fulci (ma prima ancora arrivò Mario Bava), soprattutto negli anni
70 e in parte negli 80. Tempi eroici in cui dire “di genere”
aveva una valenza diversa da quella odierna. Principalmente
dispregiativa. E in cui venivano prodotte pellicole di una genialità
artigianale che spesso sarebbero state rivalutate solo dopo un lungo
e colpevole atteggiamento di sufficienza culturale. Il film di
Misischia (esordiente alla regia sul grande schermo, ma già rodato
alla scuderia dei Manetti Bros) subisce l'ennesima angheria di essere
distribuito a Ferragosto, per di più insieme a blockbuster con i
quali la partita al botteghino è impari in partenza. E proprio per
questo, pur con tutte le sue imperfezioni, è un film che si dovrebbe
scoprire, godere e valorizzare. Sempre che – elemento necessario –
siate cinefili e soprattutto amiate l'horror. O quel tono di
sufficienza, molto anni 70, potrebbe tornare a mordervi come gli
zombi di cui stiamo per parlare. Sì, perchè il film di Daniele
Misischia si basa tutto su un'idea e sulla tecnica per fare di un
limite virtù. E sono sforzi che bisogna sapere apprezzare.
“The End? L'inferno fuori”
è un film horror, dunque.
Anzi, uno zombi-movie, di quelli che ormai fanno etichetta a sé. Ma
è anche un esercizio di stile che combina più sottogeneri, tutti
ascrivibili alla categoria più ampia del thriller.
Il film vive inteamente
nel suo spunto di partenza. Un apocalisse zombi (o di infetti furiosi
e cannibali, ormai non importa più). Un uomo intrappolato in uno
spazio angusto. Una serie di eventi terrificanti che si succedono al
di fuori, e di cui c'è dato scoprire solo il punto di vista del
protagonista. Quello offerto dalla finestra ricavata dalle ante
semiaperte di un ascensore bloccato tra
due piani. Rifugio e nello
stesso tempo strumento di tortura, che porta lo spettatore a
chiedersi dove sarebbe effettivamente meglio trovarsi? Se in trappola
con il protagonista o fuori, alla mercé di un'orda di zombi
famelici. Se in fuga là dove
si può essere
sbranati a ogni angolo o rinchiusi dove con molta probabilità si
farà la fine del topo.
Potremmo
definire questo sottogenere, un “punto di vista relativo”. Una
narrazione classica ridotta alla visione soggettiva e parziale di un
personaggio defilato. Un po' come nel film “Cloverfield”,
dove la classica invasione del mostro gigante che mette a ferro e
fuoco una città è raccontata
attraverso gli occhi di un pugno di cittadini ignari di quanto sta
succedendo, quasi venisse
data voce alle comparse che
si solito si limitano a correre urlando.
Inevitabile è anche pensare
a “Buried”,
film interamente ambientato
nel chiuso di una cassa dove
un uomo, sepolto vivo, cerca di darsi aiuto con un telefono e pochi
altri arnesi. Il tutto collocato nello scenario ormai canonizzato
dell'epidemia zombesca, in cui l'appassionato di horror sa perfettamente che cosa sta
succedendo, ma dove l'ansia e il senso dello spettacolo è fornito
dal crescendo di consapevolezza, terrore e reazione, dell'uomo
intrappolato in uno spazio che ne limita i movimenti e la
comprensione dei fatti. C'è
poi quell'elemento che risale addirittura al
teatro del Grand Guignol
e agli orrori suggeriti più che mostrati. Sempre attraverso il
telefono, come nel classico “Au telephone”
del drammaturgo francese André De Lorde, in cui un uomo in viaggio,
attraverso l'apparecchio telefonico appena installato
nelle case del primo novecento,
ascolta
impotente i suoni che
descrivono l'assassinio della
sua famiglia.
Il
cinema di zombi, a partire dal suo capostipite romeriano, “La
notte dei morti viventi”,
nasce da subito come cinema della costrizione. Racconto d'assedio,
dove l'inferno fuori è catalizzatore di discordia e orrori interni,
secondo l'idea infernale immaginata da Jean Paul Sartre in “Porta
Chiusa”. Qui
l'assedio riguarda un singolo e il catalizzatore della paura non sono
tanto gli zombi, quanto l'ignoranza di cosa succede fuori, e gli
inesorabili sviluppi della
catastrofe che si rivelano in
dettagli mostrati dapprima con piccoli squarci di mondo esterno, e
poi con una progressiva penetrazione dell'orrore all'interno. Se
nella trilogia di George Romero gli zombi assediavano l'ordine
costituito, la famiglia, l'istituzione, la società dei consumi, le
forze dell'ordine e alla fine dichiaratamente il capitalismo, in
“The End?” si
scatenano all'interno di un complesso aziendale e tengono
emblematicamente in ostaggio un imprenditore cinico e dispotico.
Potremmo definirla una
miniatura dei topos romeriani, dove sia il luogo dell'assedio (una
casa, un ipermercato, un bunker... qui lo spazio angusto di un
ascensore) e i totem da abbattere (qui riassunti in un unico
personaggio simbolo) sono felicemente concentrati con un ottimo uso
del ritmo e dello spazio scenico volutamente ridotto.
Allessandro
Roja, volto della serie
televisiva “Romanzo criminale”
è funzionale al suo personaggio e alla lenta evoluzione (anche
quella simbolica che affronterà). La performance non è forse
memorabile, ma non necessita di esserlo in quanto il film vive di
attese, suggestioni e vampate di terrore che
l'interprete è in grado di reggere. Più incisivo è il giovane Claudio Camilli, che riempie lo schermo con la sua mole e il suo carisma non appena entra in scena, ed è il perno di alcuni dei momenti più intensi della pellicola. I comprimari, la maggior parte dei quali appaiono solo di sfuggita, e
la moglie del protagonista (Carolina Crescentini, presente solo come
voce al telefono) sono veicolo di tutti quei cliché che lo
spettatore si aspetta, e che fanno parte del lavoro di attenta
miniatura che la regia offre a un pubblico scafato, ma in grado di
apprezzare la tecnica del racconto.
In
definitiva, “The End? L'inferno fuori” è
un riuscito, piacevole giocattolo per mettere paura. Senza
esagerazioni, è un'opera prima da promuovere per la forma e la
capacità di osare. Una variazione su un tema ormai abusato che trova
i suoi punti di forza nella sottrazione anziché nell'eccesso. Un
giocattolo che riesce persino a spaventare in più di una scena là
dove pellicole mainstream hanno ormai rinunciato, oppure falliscono
nel più frustrante
dei
ja vu. E se dovrà esserci un ritorno al cinema di genere italiano,
magari possiamo considerare proprio il film di Daniele Misischia il
punto da cui ripartire.